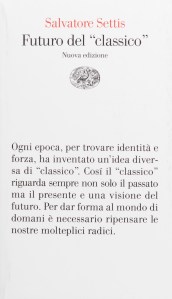di Ivan Quaroni
Invasione americana
Il Pop Surrealism, conosciuto anche col meno lusinghiero nome di Lowbrow Art – un termine intraducibile in italiano, ma che sostanzialmente indica un’arte popolare, incolta, corriva -, è stato un movimento artistico americano che si è affermato negli anni Novanta del secolo scorso in antitesi alle dominanti tendenze concettuali del mondo artistico ufficiale. Questo movimento ha saputo raccogliere e rielaborare tutto il coagulo delle esperienze della sottocultura statunitense, dalle Hot Rod (le auto customizzate e decorate con motivi fiammanti) all’estetica del surf e dello skateboard, dal fumetto psichedelico al punk rock, dall’immaginario dei cartoni animati ai B-movie horror e fantascientifici, inglobando, nel corso del tempo, codici visivi considerati a torto marginali, come il graffitismo, il tatuaggio, la grafica, l’illustrazione, la folk art o quella dei cosiddetti outsider.
Nonostante le sue origini americane, il Pop Surrealismo si è trasformato, nei primi anni del nuovo millennio, in un movimento internazionale che ha sparso i suoi semi in ogni angolo del globo. Due sono stati gli elementi catalitici che ne hanno favorito la diffusione planetaria: internet e la nascita di riviste come Juxtapoz e Hi-Fructose, che hanno svolto una funzione “evangelizzatrice” nella propagazione di questo nuovo “verbo figurativo”, caratterizzato dal ricorso a un immaginario insieme popolare e fantastico. Di qui la definizione di Pop Surrealism, che sottolinea il duplice debito verso l’arte Pop, largamente intesa come coacervo di espressioni ispirate all’iconografia massmediatica della società dei consumi, e verso il surrealismo, termine che in questo caso include non solo la corrente storica fondata da André Breton, ma tutte le forme di arte fantastica precedenti e successive.
Con l’espansione del Pop Surrealismo ben oltre i confini della controcultura americana e con la progressiva inclusione tra le sue fila di numerosi artisti che provenivano dalle più variegate esperienze artistiche, il movimento si è, però, trasformato in un contenitore ipertrofico di linguaggi e stili contrastanti che hanno finito per diluirne l’iniziale (e fondamentale) spinta antagonista, lasciando, così, spazio a una pletora di espressioni derivative.
Nel primo decennio degli anni Duemila, e fino al primo lustro della decade successiva, questa tendenza artistica si è diffusa anche in Italia, grazie alla mediazione di un manipolo di gallerie alternative e di un ristretto numero di appassionati giornalisti, critici d’arte e collezionisti. Il primo avamposto italiano del Pop Surrealismo è stata la galleria Mondo Bizzarro, fondata a Bologna nel 2000 e trasferitasi a Roma tre anni più tardi, che nella sua programmazione ospita artisti di punta del movimento come Mark Ryden, Mario Peck, Gary Baseman, Camille Rose Garcia e Todd Schorr, alternandoli a fumettisti e autori italiani come Filippo Scozzari, Roberto Baldazzini e Massimo Giacon. Nel 2007, sempre a Roma, hanno aperto i battenti anche le gallerie Mondopop e Dorothy Circus. La prima, fondata da David Vecchiato e Serena Melandri, ha saputo mescolare nomi di grido del movimento con esponenti della street art italiana e internazionale, con un approccio attento alla politica dei prezzi che, accanto ad opere originali, comprendeva multipli, poster, giocattoli e gadget firmati dagli artisti. Dorothy Circus, creata da Alexandra Mazzanti, ha invece mostrato fin dagli esordi una predilezione per opere caratterizzate da ambientazioni fiabesche e suggestioni gotiche, come Ray Caesar, Miss Van, Kukula e Tara McPherson.
Dal 2010 anche la galleria milanese Antonio Colombo Arte Contemporanea ha avviato una programmazione serrata di artisti pop surrealisti, tra i quali Ryan Heshka, Tim Biskup, Gary Baseman, Anthony Ausgang, Eric White, intervallati da artisti italiani come El Gato Chimney, Massimo Giacon, Dario Arcidiacono e Fulvia Mendini. Dal 2008 a Milano la The Don Gallery di Matteo Donini si è impegnata nella divulgazione di artisti che spaziano dalla Street art alla Lowbrow Art, proponendo mostre con lavori di Ron English, Jeremy Fish, The London Police, Microbo, Bo130 ed Ericailcane. Incursioni nel campo delle ricerche italiane affini al movimento americano vengono compiute anche dalla milanese Galleria Bonelli, che tratta le opere di Nicola Verlato, Fulvio Di Piazza e Marco Mazzoni e dalla galleria Area/b, che si fa portavoce di Italian Newbrow, uno scenario solo parzialmente assimilabile ai linguaggi pop surrealisti.
Importantissime per l’affermazione del Pop Surrealismo in Italia sono state anche le numerose mostre pubbliche, spesso organizzate con il contributo di critici curiosi e attenti alle evoluzioni delle grammatiche figurative, in spazi come il Museo Madre di Napoli (Urban Superstar Show, 2007), il Macro di Roma (Apocalypse Wow. Pop Surrealism, Neopop, Urban Art, 2009), il Museo Carandente di Spoleto (Pop Surrealism, What a Wonderfool World, 2010), la Scuola dei Mercanti di Venezia (The Emergence of Pop Imagist, 2010), il Centro Camerale Alessi di Perugia (Urban Pop Surrealismo, 2011), il Fortino di Forte dei Marmi (Italian Newbrow, 2011), il Palazzo delle Stelline di Milano (La natura squisita. Ai confini del pop, 2012). La massiccia ondata di mostre pop surrealiste è stata poi amplificata dall’attenzione dei media generalisti, ma praticamente ignorata da riviste di settore come Flash Art, il cui editore, però, ha dato alle stampe un libro dedicato al movimento Italian Newbrow(2010).
Genoma italiano
La facilità con cui in Italia attecchisce la nuova sensibilità pop surrealista nel campo delle ricerche pittoriche neofigurative è stata il sintomo di un’insofferenza diffusa verso le dinamiche elitarie e intellettualistiche che tutt’ora dominano il sistema dell’arte nostrano, arroccato su posizioni neo-concettuali che premiano le ricerche multimediali, relegando la pittura a un ruolo marginale.
A colpire gli estensori italiani di questo stile internazionale è stata soprattutto la relativa facilità con cui gli artisti americani sono riusciti a organizzare un sistema alternativo a quello ufficiale, costruendo in breve tempo una rete di relazioni con collezionisti e appassionati che hanno portato alla fondazione di riviste specializzate e spazi espositivi dedicati alla nuova temperie contro-culturale del Surrealismo Pop. Un sistema alla cui diffusione hanno contribuito peraltro anche istituzioni pubbliche come, ad esempio, il Museum Of Contemporary Art di Los Angeles, e gallerie universitarie come quelle della CSU Northridge e della Otis Parsons School of Design[1].
Più che l’armamentario iconografico, sospeso tra fantasia e immaginario pop, è stata l’abilità organizzativa e commerciale degli artisti americani a ispirare i pittori italiani, i quali, forse troppo ottimisticamente, hanno sperato di riprodurre le stesse dinamiche in un contesto che si dimostrerà, a conti fatti, assai meno ricettivo.
Sul piano strettamente formale, tuttavia, non si può dire che sia mai veramente esistito un movimento Pop Surrealista italiano, derivato da quello americano. Gli artisti che in Italia hanno risposto all’appello delle mostre pop surrealiste provenivano, infatti, da esperienze maturate, per lo più, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio nel contesto della cosiddetta Nuova Figurazione, una definizione forse non originalissima – dato che era già stata applicata ad alcune correnti pittoriche figurative del secondo dopoguerra – con cui si designava l’ambito delle indagini artistiche che guardavano alla cultura di massa, al fumetto, al cinema e alla letteratura come a inesauribili fonti d’ispirazione.
Nello specifico, molti dei linguaggi pittorici emersi in Italia in quel periodo mostravano già una propensione sia verso l’elemento fantastico, eccentrico, surreale, sia verso l’immediatezza dell’immaginario pop, consumistico e massmediatico, come dimostrano numerose esposizioni del periodo, da Sui Generis, curata nel 2000 da Alessandro Riva al PAC di Milano, a La linea dolce della Nuova Figurazione e Ars in Fabula, entrambe curate da Maurizio Sciaccaluga rispettivamente alla Galleria Annovi di Sassuolo (2001) e al Palazzo Pretorio di Certaldo (2006), da La Nuova Figurazione Italiana… To be Continued (2007), curata da Chiara Canali alla Fabbrica Borroni di Bollate, alla rassegna Arte italiana 1968-2007, curata nel 2007 da Vittorio Sgarbi al Palazzo Reale di Milano, fino alla celebre mostra milanese Street Art Sweet Art (2007), ancora una volta curata da Alessandro Riva al PAC.
Sono anni, quelli della prima decade del Duemila, in cui l’attenzione verso i giovani pittori e scultori figurativi è ai massimi livelli, grazie anche al costante monitoraggio dei premi nazionali e all’interessamento delle riviste di settore, che documentano l’emergere di una scena artistica capace di combinare la tensione verso il fantastico con le inedite possibilità di saccheggio dell’immaginario mediatico offerte da internet. Il risultato è una miscela figurativa esplosiva, caratterizzata non solo dall’affermazione di linguaggi che fanno appello all’immediatezza e alla godibilità delle immagini pop, ma anche da una attitudine alla contaminazione dei codici espressivi e da una volontà di esplorazione dei territori della fiction che si ritrovano, qualche anno più tardi, anche nella scena Italian Newbrow, che nasce come diretta conseguenza delle esplorazioni neofigurative. Come notava Gianni Canova in un articolo del 2011, «Italian Newbrow è la rivendicazione orgogliosa di tutto il bazar delle iconografie popolari – non solo il fumetto, la Tv, il cinema di serie B, ma anche il tatuaggio, il graffito, il cartoon, il pop design – assemblate con la tecnica del cut & paste digitale (che poi è l’evoluzione del collage cubo-futurista)»[2]. Si può dire, infatti, che gran parte degli elementi che contraddistinguono il Pop Surrealism – cioè le pratiche di saccheggio mediatico, i procedimenti di mash up iconografico, l’insistenza sull’elemento fiabesco e fantastico – siano già presenti nella Nuova Figurazione nel momento in cui, proprio a partire da quel fatidico anno 2007, la corrente americana comincia a diffondersi in Italia. Se esistono analogie tra la pittura fantastica e pop italiana, ben rappresentata in questa mostra, è il movimento Lowbrow, queste riguardano spesso il comune utilizzo di fonti iconografiche derivate dal web, e dunque la confidenza, tipica della cosiddetta Google generation, con gli strumenti digitali, oltre che l’evidente insofferenza per le grammatiche post-concettuali che dominano il circuito dell’arte “alta”, o presunta tale.
Eccentrici, apocalittici, pop
Sarebbe un segno di pigrizia critica liquidare come Pop Surrealista tutta l’arte italiana contemporanea che abbia un carattere insieme pop e immaginista. Le genealogie delle ricerche pittoriche e plastiche in questo campo sono, infatti, le più variegate e, spesso (ma non sempre), poco o nulla hanno in comune con quelle dei colleghi americani.
La storia di Massimo Giacon (Padova, 1961), ad esempio, parte alla fine degli anni Settanta, durante il periodo aureo del fumetto italiano, quello che ha dato i natali a personaggi come Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli. Dopo l’esordio in riviste di culto come Frigidaire, Linus, Alter e Nova Express Blue, Giacon ha collezionato una serie di esperienze in diversi ambiti creativi, passando dal fumetto alla musica, dal design alla performance multimediale, fino alla pittura e alla scultura. Tutta la sua produzione – che include numerose graphic novel,oggetti realizzati per Memphis e per Alessi, dischi di band new wave e post-punk (come gli Spirocheta Pergoli e I Nipoti del Faraone), e naturalmente illustrazioni, disegni e dipinti – è attraversata da una vena di bizzarria, da una gioiosa e anarchica stravaganza che ritroviamo anche nelle sue ceramiche, oggetti disfunzionali che raccontano storie fantastiche, in bilico tra il comico e il noir.
Pur avendo esposto in diverse occasioni con una delle gallerie portabandiera del Pop Surrealism americano, la Jonathan LeVine di New York, il retroterra in cui si sviluppa la pittura di Fulvio Di Piazza (Siracusa, 1969) è quello delle espressioni neofigurative italiane dei primi anni Duemila. Immaginifico, metamorfico, alchemico, il suo codice visivo è incentrato sulla trasfigurazione. Come un novello Arcimboldo, l’artista tramuta le forme dei luoghi e dei volti in una nuova morfologia terrestre, sospesa tra l’incanto dei paesaggi vulcanici della sua terra, la Sicilia, e le visioni distopiche della fantascienza. Il risultato è una pittura dettagliata, iper-tecnica, che seduce lo sguardo dell’osservatore attraverso la resa mimetica di un cosmo di pura invenzione, dove monti, colline, avvallamenti e radure sembrano il prodotto di un cataclismatico progetto di terraforming.
L’arte ipermanierista di Nicola Verlato (Verona, 1965), ossessionata dalle torsioni anatomiche e dalle ipertrofie muscolari, è il prodotto dell’influenza delle moderne tecniche digitali di modellazione 3D, combinate con la lezione della pittura rinascimentale e lo stile dei fumetti fantascientifici e horror pubblicati su Metal Hurlant tra gli anni Settanta e Ottanta. Le opere dell’artista sono il prodotto di un processo che combina tecniche classiche e tecnologie digitali. Molti dei suoi soggetti, infatti, vengono prima realizzati in forma di studio plastico, poi passati al filtro della modellazione 3D e infine tradotti in dipinti e sculture. Oltre all’immaginario surreale e fantastico, è forse proprio questa artigianalità complessa, un mix di tradizione e modernità, ad aver contribuito al successo americano dell’artista, che non solo ha vissuto per un lungo periodo a Los Angeles, ma è, di fatto, diventato un esponente del Pop Surrealism partecipando alla mostra In the Land of Retinal Delights (2008, Laguna Art Museum, Laguna Beach, California) e intrecciando relazioni con i collezionisti e i critici più significativi del movimento, come il compianto Greg Escalante, co-fondatore della rivista Juxtapoz e della galleria Copro/Nason.
Dalle fila di Italian Newbrow, provengono gli artisti Giuseppe Veneziano, Laurina Paperina e Vanni Cuoghi, che integrano nelle loro ricerche elementi dell’immaginario pop, sviluppandoli, però, in modo molto personale. Al crocevia tra realtà e finzione, arte e storia, cronaca e fantasia si colloca l’indagine di Giuseppe Veneziano (Mazzarino, 1971), architetto approdato alla pittura dopo un’esperienza come vignettista per il Giornale di Sicilia. I suoi lavori, caratterizzati da uno stile piatto e sintetico di marca new-pop, raccontano l’ambiguità della società contemporanea attraverso l’accostamento di elementi veridici e immaginari, che mostrano il progressivo assottigliarsi del confine che separa la realtà dalla fiction. L’artista si serve di personaggi riconoscibili della mitologia, della storia dell’arte, dello spettacolo, ma anche del fumetto, dei cartoni animati e della cronaca per raccontare, con un linguaggio chiaro e intellegibile, le vicende del nostro tempo. Attraverso un registro ironico e dissacrante, Veneziano mostra il carattere fondamentalmente equivoco della vicenda umana, una pantomima di maschere di cui svela vizi privati e pubbliche virtù.
Laurina Paperina (Rovereto, 1980) associa i riferimenti alla cultura pop a uno stile pittorico quasi infantile, per trattare con feroce ironia e cinico candore tematiche che spaziano dall’escatologico allo scatologico. Riprendendo e deformando l’iconografia dei trionfi della morte e delle danze macabre medievali, l’artista inscena una sorta di odierno inferno massmediatico, gremito di figure ripescate dai fumetti e dai cartoni animati, dal cinema horror e di fantascienza, ma anche dalla storia dell’arte antica e contemporanea. Le sue opere si possono leggere come una sequenza di racconti horror o, meglio, di novelle splatter che indugiano nella descrizione, insieme sadica e divertita, di una pletora di massacri e carneficine che paiono uscite dalle pagine – rigorosamente miniate – di una moderna Apocalisse nerd.
Abbandonati gli iniziali legami con la cultura pop, Vanni Cuoghi (Genova, 1966) ha sviluppato una pittura che insiste sulla costruzione di microcosmi metafisici in cui si avverte l’irrompere del perturbante o del weird, una dimensione estetica bizzarra, derivata dalla combinazione di elementi che non appartengono allo stesso contesto. Secondo Mark Fisher, infatti, “la forma artistica più appropriata al weird è quella del montaggio”[3]. I dipinti e i teatrini miniaturizzati di Cuoghi costruiscono universi improbabili attraverso la riproduzione di frammenti del mondo reale assemblati in maniera incongrua. Nella serie intitolata La messa in scena della pittura, l’artista rivela il carattere smaccatamente artificiale dell’arte, intesa come una forma di finzione che spalanca le porte a una dimensione sconosciuta, estranea, in cui si manifestano i segni di un’autentica esternalità. Quello rappresentato da Cuoghi non è più il vecchio mondo a misura d’uomo, ma la realtà fuori di sesto e definitivamente destabilizzata che ci attende alla fine dell’antropocene.
Dalla passione per i manga e gli anime giapponesi e, in generale, per i cartoni animati, nasce la grammatica artistica di Giovanni Motta (Verona, 1971), in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I suoi lavori, progettati con software tecnologici, possono assumere la forma di opere digitali oppure di sculture realizzate con la stampa 3D o di quadri meticolosamente dipinti a mano. Tema della sua ricerca – stilisticamente affine a quella del movimento Superflat di Takashi Murakami – è il bambino interiore, personificato nella figura di Jonny Boy, un personaggio dall’anatomia ipertrofica che sembra disegnata da un mangaka. Questo puer aeternus, recentemente diventato il protagonista del primo fumetto digitale realizzato dall’artista, intitolato Megborg, è figura ricorrente di un immaginario scaturito dall’esplorazione delle memorie infantili, considerate come un inesauribile giacimento di entusiasmo e fonti d’ispirazione.
L’universo infantile è anche il soggetto delle opere di Luciano Civettini (Trento, 1967), pittore innamorato delle atmosfere fiabesche dal carattere ambiguo e straniante. Nei suoi dipinti coesistono riferimenti ai personaggi del mondo disneyano, come ad esempio Topolino o Pippo, e figure di bimbi che incarnano lo sguardo ingenuo e innocente attraverso cui l’artista filtra la propria visione pessimistica di un mondo funestato da guerre e devastazioni d’ogni tipo. Il suo linguaggio è segnato da un lirismo sognante e stupefatto che rimanda alle grammatiche folk di artisti giapponesi come Makiko Kudo, Aya Takano e Yoshitomo Nara, o a pittori americani del calibro di Tim McCormick e Gary Baseman, rispetto ai quali si distingue per il gradiente marcatamente post-romantico ed emozionale delle sue creazioni.
Ilaria Del Monte (Taranto, 1985) eredita dalla tradizione femminile del surrealismo – quella sotterranea di Leonor Fini, Dorothea Tanning, Leonora Carrington e Remedios Varo -, la visione di una realtà in cui il quotidiano e il soprannaturale si fondono senza soluzione di continuità, come in certi romanzi della corrente letteraria del Realismo Magico sudamericano. Eppure, dal punto di vista strettamente formale, la sua pittura è anche figlia dell’altro Realismo Magico, quello degli artisti italiani e tedeschi a cavallo tra le due guerre, da cui Del Monte mutua l’atmosfera di sospensione in cui immerge le protagoniste dei suoi racconti. Al centro delle visioni si staglia l’immagine femminea, rinchiusa nelle asfittiche stanze di una prigione domestica, un luogo claustrale, stranamente permeato da germinazioni e inflorescenze naturali, uno spazio d’innesti rizomatici e di bestiali incursioni, che rendono labile il confine tra i generi del paesaggio e dell’interno borghese.
Nella sua pittura, vicina agli stilemi del Pop Surrealism, Nicola Caredda (Cagliari, 1981) rappresenta un universo distopico fatto di macerie e detriti dell’età post-moderna. I suoi paesaggi apocalittici, meticolosamente dipinti con colori saturi, mostrano, infatti, i residui di mondo definitivamente tramontato a causa di una catastrofe nucleare o ecologica. Un universo disabitato e silente, costellato di ruderi industriali e malinconici reperti della società capitalista, dove la natura torna a occupare gli spazi che l’uomo un tempo le aveva sottratto. I dipinti di Caredda mostrano ciò che resta alla fine dell’antropocene, l’attuale epoca geologica dominata dalle attività umane che, secondo le previsioni del biologo Eugene F. Stoemer, sono la causa delle irreversibili alterazioni ambientali e climatiche dell’ecosistema terrestre.
Marco Mazzoni (Tortona, 1982) è artista e illustratore che è stato in stretto contatto col mondo del Pop Surrealismamericano. Ha esposto, infatti, alla Jonathan LeVine Gallery e alla Roq La Rue di Seattle ed i suoi lavori sono stati pubblicati su riviste come Juxtapoz e Hi Fructose. La sua ricerca, però, è nata in Italia, dove ha maturato uno stile disegnativo unico, col quale ha creato immagini in cui il volto femminile si fonde con forme zoomorfe e vegetali. Mazzoni usa esclusivamente matite colorate per delineare i contorni di un universo fantastico in cui uomo e natura sembrano perfettamente integrati. Molte sue opere sono eseguite su taccuini Moleskine, sulle cui pagine l’artista dispiega il regesto delle sue metamorfosi organiche, tutte giocate sull’alternanza di luci ed ombre pazientemente ordite con la tecnica del chiaroscuro.
Zoe Lacchei è un artista nei cui lavori ricorrono spesso riferimenti alla cultura visiva giapponese, come, ad esempio, nel caso di The Girl Who Fight The Wolf (2020), un dipinto su carta che rimanda alla Principessa Mononoke, personaggio protagonista dell’omonimo anime di Hayao Miyazaki, o come nell’opera Neo Shunga #3 – Tigers (2019), dove l’artista reinterpreta l’antica tradizione erotica delle “immagini del mondo fluttuante” con un linguaggio che contamina fotografia e pittura. Altri suoi lavoriispirati alla tradizione erotica del Sol Levante (The Geisha Project) sono, invece, stati pubblicati sulla rivista Juxtapoz. Tra le sue collaborazioni più prestigiose c’è anche quella con il cantante Marilyn Manson, per il quale ha realizzato le illustrazioni dell’album The Golden Age of Grotesque (2004), poi pubblicate nella raccolta Marilyn Manson Metamorphosis: The Art of Zoe Lacchei. Oltre ad aver pubblicato le sue illustrazioni con case editrici americane e francesi, Lacchei ha esposto con importanti gallerie del circuito pop surrealista, come La Luz De Jesus di Los Angeles, la Vanilla Gallery di Tokyo e le italiane Mondo Bizzarro e Dorothy Circus. Tra i lavori qui esposti lavori qui esposti sono presenti anche due tondi, The Bleeding Heart of Daenerys Targaryen(2019) e The Bleeding Heart of Jon Snow (2019), originali tributi alla popolare saga televisiva di Game of Thrones.
Tra gli artisti provenienti dalla street art, e invitati a realizzare un dipinto murale in occasione di questa mostra, ci sono nomi storici del graffitismo italiano come Ozmo e Pao, che hanno partecipato alla storica esposizione del PAC di Milano, Street Art Sweet Art, ed El Gato Chimney, ex membro della Krudality Crew di Milano. Tra questi, El Gato Chimney(Milano, 1981) è forse l’artista più surreale, suggestionato non solo dall’arte sacra, tribale e folk e dalla letteratura alchemica, esoterica e spiritualista, ma anche dallo stile dei bestiari medievali e dall’immaginario di pittori come Pieter Bruegel il Vecchio e Hieronymus Bosch. La sua arte, popolata di figure zoomorfe simili ai grilli gotici di cui parla Jurgis Baltrušaitis in quel fenomenale catalogo di bizzarrie ed esotismi che è Il medioevo fantastico[4], è un distillato visivo che combina l’ansia catalogatoria di raffinati naturalisti, come l’italiano Ulisse Aldovrandi, con l’anelito trascendentale e fantastico dei miniaturisti di Libri d’Ore. El Gato Chimney costruisce, attraverso una partitura grafica minuziosa e dettagliata, un mondo di pura invenzione, che appare, però, come la trasposizione allegorica (e soprannaturale) dei dissidi e dei conflitti che agitano la dimensione interiore dell’uomo, eternamente diviso tra istinto e ragione, in perpetua guerra con sé stesso.
Legato alla storia del graffitismo milanese, Pao (Milano, 1977) ha iniziato la sua carriera dipingendo i suoi celebri pinguini sui paracarri di cemento sparsi nel tessuto urbano meneghino. Approdato poi alla pittura e alla scultura, ha ampliato il suo vocabolario visivo con uno stile che rimanda alle tanto alle illustrazioni per l’infanzia, quanto ai cartoni animati dello Studio Ghibli, pur mantenendo costante il riferimento alle proprie origini di street-artista. Ironiche e sognanti, le sue creazioni assumono la forma di grandi quadri o di sculture in vetroresina, ma anche di dipinti murali, grafiche e oggetti di merchandising che reiterano la sua grammatica fiabesca, connotata da un linguaggio pop immediatamente riconoscibile, e soprattutto universalmente comprensibile. La sua è, dunque, un’opera multimediale, che dissemina il proprio codice visivo fuori dai ristretti confini dell’arte contemporanea, penetrando ogni ambito della creatività.
Il lavoro di Ozmo (Pontedera, 1975), arrivato a Milano da Firenze nel 2001, si caratterizza da subito per la realizzazione di grandi dipinti murali in spazi alternativi e centri sociali (come il mitico Leoncavallo) grazie ai quali fa conoscere il suo stile eclettico, un esplosivo miscuglio di immaginario underground e riferimenti alla storia dell’arte. Artista curioso, in perenne evoluzione, Ozmo si distingue dagli altri graffitisti per lo sperimentalismo della sua ricerca, che lo ha portato, nel tempo, a modificare costantemente stilemi, materiali e modalità d’intervento, assecondando, così, una pratica metodologica che ha molto in comune con le indagini concettuali. I suoi murali possono infatti assumere, come in questo caso, le sembianze di un’installazione site specific dove la pittura, intesa come disciplina espansa che include supporti differenti, si offre come un condensato semiotico, una babele di riferimenti che spaziano dalla cultura alta a quella popolare.
Concludono questa rassegna, dedicata all’arte fantastica, i due cameo di Fatima Messana e di Vesod, che si offrono come ulteriori variabili di questa propensione eccentrica e bizzarra delle ricerche neofigurative italiane. Fatima Messana (Severodvinsk, Arkhangelsk Oblast, 1986) è una scultrice italiana di origini russe, che indaga il corpo come territorio di modificazioni e ibridazioni post-umane, confrontandosi con la tradizione dell’iconografia sacra e, talvolta, con il mondo della cronaca, da cui trae spunto per creare immagini simboliche e provocatorie. Un esempio è Capra!, opera, il cui titolo rimanda alla famosa e ripetuta esclamazione di Vittorio Sgarbi, che intende far riflettere sull’ignoranza come radice dei mali che affliggono l’umanità.
Vesod (Torino, 1981) è, invece, un artista urbano che ha esordito negli anni Novanta. Laureato in matematica e membro attivo della SCO crew, un gruppo che sperimenta l’interazione tra musica e disegno, Vesod è soprattutto autore di grandi dipinti murali e di opere su tela che sono il prodotto della fusione tra il dinamismo futurista e la tradizione anatomica dell’arte rinascimentale. Il risultato di questa compenetrazione di corpi e spazi è la creazione di visioni sospese, cristallizzate nelle forme di una geometria adamantina.
[1] Ivan Quaroni, Beautiful Dreamers. Il nuovo sogno americano tra Lowbrow Art e Pop Surrealism, 2017, Edizioni Falsopiano, Alessandria, p. 143.
[2] Gianni Canova, Idiota a chi?, «Il Fatto Quotidiano», venerdì 11 novembre 2011.
[3] Mark Fisher, The Weird and The Eerie. Lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo, Minimum Fax, Roma, 2016, p. 10.
[4] Jurgis Baltrušaitis, Il Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, Adelphi, Milano.